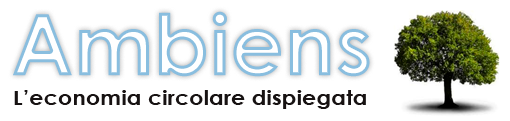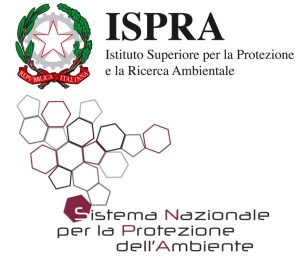MASE: pubblicato il decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia. L’entrata in vigore Il Decreto è entrato in vigore lo scoro 24 gennaio, dopo la registrazione della Corte dei Conti