

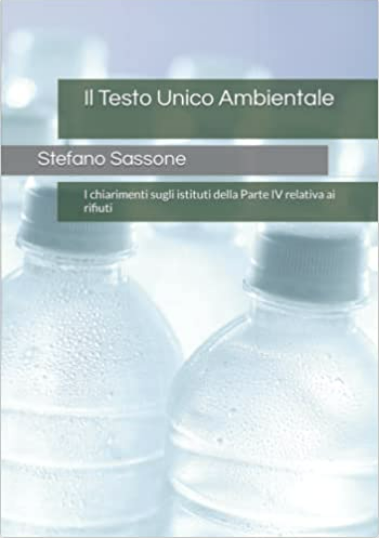

Pubblicato da ISPRA il rapporto sui danni ambientali per il ‘23
Rilasciata dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una nuova edizione del rapporto sui danni ambientali.
Cosa contiene il rapporto
Premesso che le statistiche descrittive elaborate dall’Istituto fanno riferimento al biennio 21-22, dal rapporto attuale emerge, con grande evidenza, uno scenario caratterizzato da un forte dinamismo sia sul piano tecnico/scientifico, sia sul piano gestionale: negli ultimi 6/7 anni si è assistito, infatti, ad “un inedito sviluppo delle procedure, degli assetti organizzativi e delle metodologie nel cui ambito si svolge l’attività istruttoria di valutazione”.
Tale sviluppo[1] ha concorso a portare in una nuova dimensione gli input e gli output dell’attività di valutazione in questo complesso settore:
- Sul piano degli input si è progressivamente rafforzato e perfezionato, anche grazie all’azione svolta per la diffusione della conoscenza della materia, il sistema di attivazioni dello Stato in via amministrativa da parte di soggetti pubblici e privati, come enti territoriali, associazioni e cittadini.
- Sul piano degli output si è specularmente rafforzata, anche grazie alla capacità dimostrata dal SNPA di realizzare istruttorie complesse in tempi idonei, la propensione dello Stato a gestire l’azione di danno ambientale in sede di procedura amministrativa, sede che, per definizione, mette in gioco in modo diretto le scelte e le responsabilità dell’amministrazione.
Si è allo stesso tempo costruito, sempre sul piano degli output, un sistema di “controllo ambientale” sul territorio, atteso che l’eccezionale numero di istruttorie SNPA (quasi un centinaio ogni anno) permette di evidenziare situazioni di criticità ambientale che, anche quando non integrano i requisiti del danno o della minaccia, sono oggi motivo di segnalazione da parte del Ministero agli enti territoriali competenti ai fini di una idonea risoluzione.
Le possibili casistiche di danno ambientale individuate
Nell’ambito del Rapporto, ISPRA individua due tipologie specifiche:
- Per i casi di “tipologia A”, con una situazione di sospetto di danno, la procedura prevede un primo inquadramento del caso dal punto di vista giuridico e territoriale da parte di ISPRA e la successiva raccolta di dati e informazioni da parte dell’Agenzia competente, a cui spetta anche la formulazione della proposta di valutazione in merito alla sussistenza di danni ambientali;
- Per i casi di “tipologia B”, invece, per i quali il danno o la minaccia sono già stati evidenziati e il supporto tecnico interessa la corretta individuazione delle misure di prevenzione o riparazione, la procedura prevede una istruttoria di approfondimento che, attraverso l’interlocuzione con l’Agenzia e, in alcuni casi, con gli enti regionali e locali, pervenga ad una conclusione condivisa.
Per maggiori informazioni
Consultare la pubblicazione a: https://www.isprambiente.gov.it/files2024/pubblicazioni/rapporti/rapporto-danno-2023.pdf
Consultare la pagina dedicata sul sito di ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-danno-ambientale-in-italia-attivita-del-snpa-e-quadro-delle-azioni-2021-2022-ed-2023
[1] Legato, secondo l’Istituto, principalmente a: istituzione delle Reti SNPA del danno ambientale, adozione delle procedure SNPA per le istruttorie tecniche, elaborazione della Linea Guida SNPA sui metodi di accertamento del danno ambientale e azione di formazione e divulgazione al pubblico.


Al via il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
È stato approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
Il Decreto
Con Decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, è stato approvato dal MASE il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC).
Di cosa si tratta
E’ il piano che consente di dare attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata avviata l’elaborazione del Piano nazionale di adattamento (PNACC).
Il piano è stato sottoposto a procedimento di VAS.
A giugno del 2020 l’Autorità proponente ex Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria del MiTE ha trasmesso all’Autorità competente per la VAS l’istanza di verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano nazionale di adattamento, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 152/2006. Nel mese di ottobre 2020 l’Autorità competente ha determinato che il Piano dovesse essere sottoposto al procedimento di VAS.
Pertanto, a gennaio del 2021 è stata trasmessa all’Autorità competente l’istanza per la Procedura di VAS – fase di scoping, art. 13 D.Lgs. 152/2006. Nel mese di giugno 2021 l’Autorità competente ha comunicato il termine della fase di scoping e ha trasmesso il parere della Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (Parere n. 13 del 03/05/2021).
Obiettivo perseguito
Si tratta di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l’attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle criticità riscontrate, e per l’integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti.
Inoltre, con esso si intende:
- ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;
- migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici;
- trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.
In particolare, il Piano intende definire quali debbano essere i percorsi settoriali e/o locali di adattamento ai cambiamenti climatici, e ciò attraverso la costituzione di una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi utile a tale scopo.
Si deve, infatti, contenere la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentare la resilienza agli stessi e a migliorare le possibilità di sfruttamento di eventuali opportunità.
Le parti in cui viene articolato
Esso viene strutturato come di seguito:
La struttura del PNACC è articolata come segue:
1. Il quadro giuridico di riferimento
2. Il quadro climatico nazionale
3. Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali
4. Misure e azioni del PNACC
5. Finanziare l’adattamento ai cambiamenti climatici
6. Governance dell’adattamento.

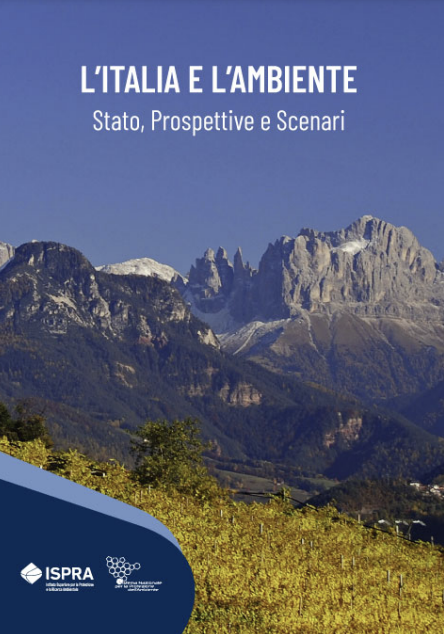
“L’Italia e l’Ambiente: Stato, Prospettive e Scenari”
Con una pubblicazione di 194 pagine, ISPRA offre una lettura complessiva dello stato dell’ambiente in Italia osservato con la lente delle principali strategie economico-ambientali quali European Green Deal e VIII Programma d’Azione per l’ambiente europeo. Il testo e le principali evidenze del documento.
La presentazione del lavoro
ISPRA, con la pubblicazione “L’Italia e l’Ambiente: Stato, Prospettive e Scenari” offre una lettura complessiva dello stato dell’ambiente in Italia, secondo le forme di programmazione e pianificazione definite dalla Comunità e dal nostro Paese.
Essa viene articolata su vari temi, con riferimento ai cambiamenti climatici, all’Economia circolare, Verso l’inquinamento zero, alla Biodiversità e al conservazione del capitale naturale.
La genesi della pubblicazione
Essa è frutto del nuovo piano triennale di azione 2022-2024, con il quale viene confermato ruolo istituzionale, autonomo e imparziale, per la protezione dell’ambiente, combinando la ricerca con il mandato di produzione e diffusione delle informazioni ambientali.
Il contenuto
Con la pubblicazione annuale, ISPRA aggiorna proprio core set indicatori (Banca dati Indicatori Ambientali) in linea con i nuovi obblighi di legge, con le più recenti evoluzioni metodologiche dei principali core set internazionali, nonché, con le più importanti esperienze di reporting ambientale a livello nazionale, comunitario e internazionale. Inoltre, approfondisce l’utilizzo di strumenti metodologici idonei all’analisi integrata degli indicatori.
In ciò si sostanzia la “doppia anima” di ISPRA.
Con il presente documento ISPRA vuole rispondere alle seguenti domande: “Qual è la situazione dell’ambiente in Italia?” e “Si sta andando nella direzione ambientalmente auspicata?”
L’Ente pubblica ricorda che oggi si dispone di una mole di informazioni, serie storiche, indicatori e metriche, frutto di anni di raccolta ed elaborazione dati, idonea a rispondere a queste due domande, ed in documento rappresenta l’opportunità per valorizzare il corpus di dati ambientali di ISPRA e restituire, a un ampio pubblico di cittadini, tecnici, osservatori e decisori politici, un’interpretazione, basata su evidenze empiriche, dell’andamento rispetto agli obiettivi fissati.
I dati sono analizzati, come sopra richiamato, secondo il quadro di riferimento vigente, ed in particolare kle policies e le normative, a livello internazionale, europeo e nazionale, facendo perno specialmente sulle iniziative della galassia ONU, Green Deal, VIII Programma d’Azione per l’Ambientale europeo e Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Ogni capitolo, ciascuno dedicato a un macrotema ambientale, viene introdotto da un excursus sul contesto politico-normativo, prima di fornire una fotografia dello stato attuale, delle prospettive e degli scenari utilizzando indicatori, anche compositi, e metriche selezionate, e le tematiche ambientali di cui si dà conto sono quelle emergenti dall’VIII Programma d’Azione per l’Ambiente europeo: Cambiamenti climatici, Economia circolare, Verso l’inquinamento zero; Biodiversità e capitale naturale.
Riusciremo a raggiungere gli obiettivi fissati
Nelll’ocazione, ISPRA sottolinea come molti degli obiettivi 2020 non siano stati centrati; tuttavia, i traguardi fissati per il 2030 e il 2050 sono ancora raggiungibili, a patto si operi un mutamento profondo dei sistemi di produzione e di consumo alla base del nostro stile di vita, quali alimentazione, energia e mobilità.
I grandi progressi compiuti dall’Europa, continente-faro delle politiche ambientali negli ultimi dieci anni, non sono ancora sufficienti a raggiungere l’obiettivo di sostenibilità “vivere bene entro i limiti del pianeta” e le prospettive future non sono rosee.
Qual è la ricetta per poterli raggiungere?
L’Istituto sottolinea come la differenza la possa fare, oltre alla volontà politica, proprio lo stesso ISPRA, in qualità di supporto scientifico ai policy-makers, attraverso l’analisi rigorosa e puntuale dell’informazione ambientale.
La rottura dell’equilibrio nella relazione uomo-ambiente innesca fenomeni che stanno già avendo profonde ripercussioni sulla salute dell’uomo stesso e della biosfera nel suo complesso.
Per consultare la pubblicazione


