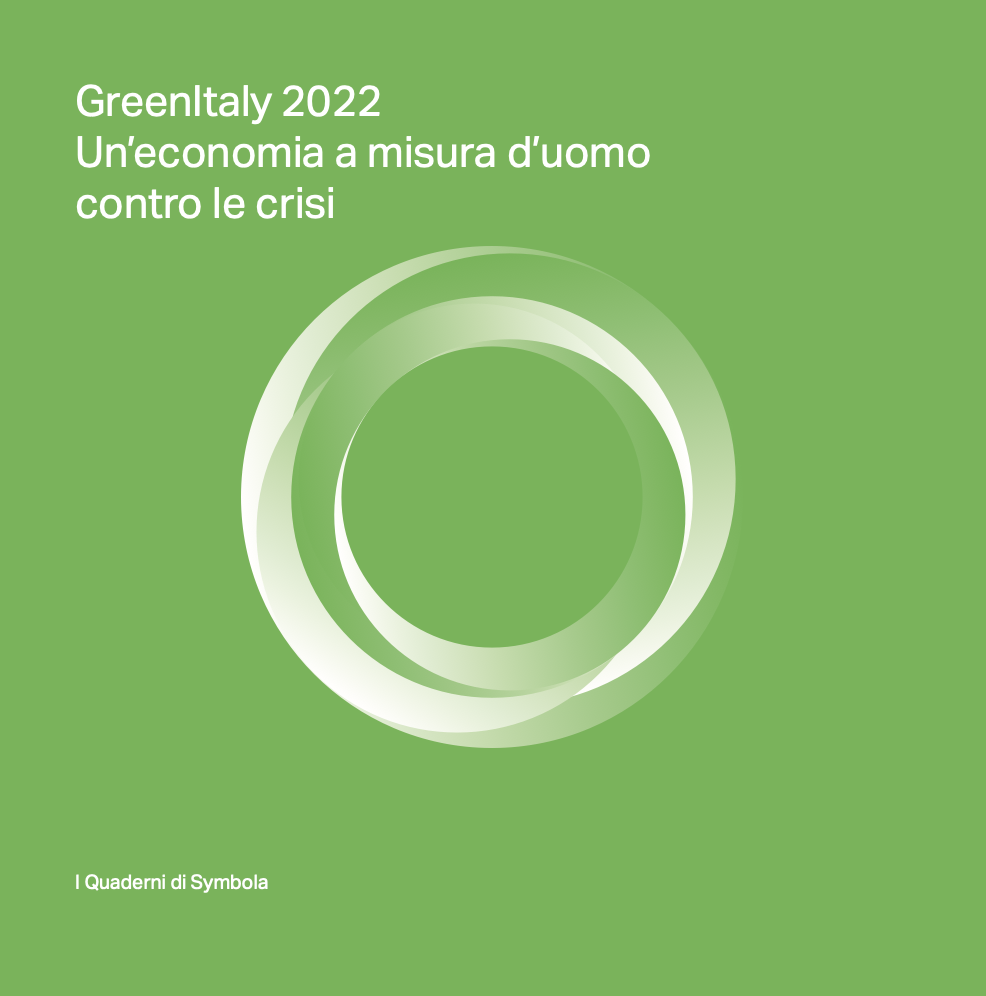È il dato che emerge da Green Book, la monografia completa del settore rifiuti urbani in Italia, rilasciata recentemente dalla Fondazione Utilitatis.
La struttura del report
Il report viene articolato in varie sezioni, ognuna delle quali viene dedicata ad aspetti specifici del settore indagato, quello ambientale, con riferimento a:
- contesto normativo di riferimento;
- aspetti di governance locale e gestionali;
- risultati conseguiti dagli operatori del comparto sotto il profilo economico e patrimoniale,
- spesa sostenuta dalle utenze finali destinatarie del servizio di igiene urbana;
- analisi degli affidamenti di tali servizi.
ISPRA ha fornito un apporto in termini di dati all’edizione 2022 del Green Book, mediante:
- un’analisi delle esportazioni e importazioni di rifiuti urbani e speciali;
- un focus sul ruolo dell’innovazione tecnologica nel settore, con particolare riferimento alla filiera della plastica[1].
I punti focali del documento
Diversi gli aspetti significativi che emergono:
Il nuovo piano d’azione sull’economia circolare UE
Nel marzo del 2020 il Parlamento europeo ha votato il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare.
Con esso vengono richieste agli Stati membri:
- misure aggiuntive per sviluppare un sistema economico e sociale pienamente circolare entro il 2050;
- ovvero la realizzazione di un sistema fondato sul riciclo.
Tale modello prevede che:
- la produzione di rifiuti venga ridotta al minimo;
- venga utilizzata maggiormente la pratica del riutilizzo come una risorsa.
Si rileva che, in merito al raggiungimento di tali obiettivi, il quadro europeo mostra una situazione piuttosto eterogenea, con Paesi a differenti velocità.
Incremento della quota della preparazione al riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti urbani
La normativa di riferimento comunitaria sul punto, contenuta nella c.d. “Direttiva quadro”, la 2008/98/CE prevedeva, entro il 2020, una percentuale di riciclo dei rifiuti urbani pari ad almeno il 50%, in termini di peso della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici (quali carta, metalli, plastica e vetro).
E nel 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani è arrivata a quota 54,4% raggiugendo l’obiettivo europeo (ISPRA).
Italia: nel 2020 impiegati 95.000 addetti nel settore per 50.000 imprese circa
Nella comunità europea sono attive 50.628 imprese nel 2019. Il valore della produzione risulta pari a circa 167 miliardi di euro. In dettaglio, nel 2020, in Italia, il settore ha registrato 13,9 miliardi di euro di valore della produzione in linea con gli altri anni (circa lo 0,8% del PIL) e occupato oltre 95.000 addetti diretti (1,6% del comparto industria).
Si rileva deficit impiantistico nelle regioni del centro-sud
Il rapporto mette in evidenza una realtà purtroppo consolidata: nel nostro Paese, le regioni centro meridionali presentano ancora un deficit impiantistico importante, che non consente la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. In questo senso, il PNRR fornisce concrete opportunità per ridurre il service divide che distingue il territorio italiano, grazie a possibili investimenti mirati a migliorare i sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti. A questo si aggiunge che nel 2022 è stata pubblicata dal MITE la proposta di Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), che costituisce una delle riforme strutturali per l’attuazione del PNRR.
Inoltre, sul piano generale, il deficit impiantistico contribuisce al differenziale di spesa per il servizio di igiene urbana tra le varie macroaree del Paese, a causa del maggiore costo sostenuto per il trasporto dei rifiuti verso impianti fuori regione: difatti nel 2020 la TARI al Sud ha raggiunto mediamente un costo di 359 euro, al Centro di 334 euro e al Nord di 282 euro.
Nella UE non vi è uno schema univoco per la gestione dei rifiuti
L’analisi dei sistemi di governance e degli schemi amministrativi adottati dai singoli Stati membri dell’Unione europea, non sembra individuare ancora soluzioni univoche per una efficace gestione del ciclo dei rifiuti. In Italia, il processo di attuazione della governance locale rimane ancora incompleto in molte Regioni. Ad oggi solo in 12 Regioni gli EGA risultano operativi in tutti gli ATO previsti, mentre nelle restanti aree si osservano situazioni di parziale operatività o totale inoperatività. Laddove gli EGA non risultano operativi, i Comuni rappresentano gli enti territorialmente competenti.
In Italia abbiamo 7.000 Gestori tra Enti locali ed Aziende
Il comparto in Italia si conferma caratterizzato da un’alta frammentazione verticale e orizzontale della gestione. Oggi risultano attivi più di 7.000 gestori (enti locali e aziende) di cui il 70% eroga una sola attività, mentre il ciclo integrato è svolto da appena il 2,4% dei gestori, ovvero circa 170 soggetti (dati ARERA).
Bandi di gara: nella grande parte dei casi l’affidamento avviene nei confronti di un solo Comune
Utilitatis, mendiante il proprio Osservatorio, ha provveduto ad analizzare un panel di 2.092 bandi per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, espletati dal 2014 al 2021, da cui emerge, fra le altre cose, che l’85% di essi prevede l’affidamento del servizio per un solo Comune, e ha una durata inferiore ai 5 anni.
10,3 e i 12,6 miliardi di euro le entrate tariffarie del servizio integrato di igiene ambientale assoggettate a regolazione ARERA
Si tratta di una stima che emerge dall’analisi delle ricadute, in termini finanziari, dovute all’applicazione del secondo periodo di regolamentazione tariffaria sul settore rifiuti realizzato da ARERA mediante al Delibera n. 363 del 3 Agosto 2021 (c.d. “MTR2”), con il quale vengono definisce i criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento, cui si aggiunge l’emanazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) si configura un quadro unico sulla qualità ambientale del servizio, qualità contrattuale e qualità tecnica. Una prima stima individua tra i 10,3 e i 12,6 miliardi di euro le entrate tariffarie del servizio integrato di igiene ambientale assoggettate a regolazione.
Le delibere dei piani economici finanziari (PEF) approvati per il 2020 da ARERA mostrano incrementi non superiori al 2% per il 45% delle predisposizioni, mentre nei restanti casi gli incrementi più elevati adottati dagli Enti territorialmente competenti (ETC) manifestano la dinamicità del settore in termini di variazione del
perimetro del servizio e miglioramento della qualità.
[1] La sezione curata da ISPRA fornisce informazioni relative ai flussi transfrontalieri di rifiuti urbani e speciali per il biennio 2019-2020. Nel 2020, sono stati esportati oltre 4,2 milioni di tonnellate di rifiuti (4,4 milioni nel 2019) a fronte di un’importazione di circa 7 milioni di tonnellate (nel 2019 erano 7,2 milioni). Dall’analisi si evince che i rifiuti urbani importati in Italia sono destinati totalmente al recupero di materia, mentre oltre il 36% di quelli esportati è destinato a recupero energetico.
Advertising
Book
Pubblicato il nuovo volume riguardante la normativa ambientale dedicato ai chiarimenti sulla parte IV del TUA, sulla gestione dei rifiuti dal titolo “Il testo unico ambientale – I chiarimenti sugli istituti della Parte IV relativa ai rifiuti“
Per comprare il Volume
Cliccare qui.
Advertising
Book
Disponibile on-line, su Amazon on-line shop, il secondo volume de “L’economia circolare dispiegata”, “La gestione dei rifiuti: per Aziende, Cittadini, Enti pubblici”, dedicato a chi vuole approfondire i temi dell’economia ambientale, della gestione dei rifiuti e della relativa disciplina tariffaria, sotto un profilo economico, legislativo e tributario.
E’ in libreria e sullo shop-on line di Amazon, il mio nuovo volume dedicato alle “Procedure Autorizzative Ambientali IIa Edizione. Cosa cambia con il “Semplificazioni bis” (DL n. 77/2021/)”.
Per comprare il Volume
Cliccare qui.
Advertising
Book
Le “Procedure Ambientali” costituisce il primo volume della nuova collana dal titolo “L’Economia circolare dispiegata”, il visibile filo rosso che lega assieme le diverse monografie che la compongono, ciascuna delle quali è stata sviluppata con l’obiettivo di evidenziare i principi cui dovrebbero essere ispirati i modi di operare di cittadini, imprese, e pubbliche amministrazioni chiamati ad implementarli, i quali possono rendere, se correttamente attuati, “circolare” il nostro sistema economico. Per acquistare la tua copia, clicca qui!