



Qualità dell’aria: in discussione la proposta di Direttiva Comunitaria presso il Senato
E’ in corso di discussione presso la Commissione Politiche UE del Senato la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria. Obiettivo dell’atto consiste nella garanzia di una maggior tutela sanitaria per i cittadini.
Il contenuto della Direttiva
La proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in discussione la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria, presso la Commissione Politiche UE del Senato, richiama i principi stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal europeo.
Gli Obiettivi
La strategia
La Comunità mira a contribuire alla realizzazione del Piano d’azione per l’inquinamento zero, ed in particolare ridurre entro il 2050 l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.
Gli obiettivi intermedi
Sarà necessario raggiungere, in tal senso, degli obiettivi intermedi, con riferimento alla riduzione, entro il 2030, di:
- almeno il 55% (rispetto al 2005) degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico (quantificati in termini di riduzione dei decessi prematuri attribuibili all’esposizione);
- almeno il 25% di quelli sugli ecosistemi, obiettivi che potranno essere perseguiti solo se si ridurranno ancora significativamente le emissioni dei principali inquinanti.
Individuazione di standard intermedi per la qualità dell’aria
Viene predisposto un approccio graduale verso la definizione degli attuali e futuri standard di qualità dell’aria dell’UE.
In particolare:
- verranno fissati standard intermedi per l’anno 2030;
- verrà sviluppata una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria entro il 2050.
Nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l’Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti “air quality guideline level” termine che può essere inteso come “livello raccomandato a cui tendere”: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%.
Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria, viene richiesto agli Stati membri di istituire un certo numero di “supersiti” ovvero dei punti di misura dove, accanto agli inquinanti monitorati di routine, si eseguano determinazioni della composizione chimica del particolato, della distribuzione dimensionale e della concentrazione in numero delle particelle ultrafini, del black carbon, del potenziale ossidativo del materiale particolato, della concentrazione di ammoniaca, di numerosi idrocarburi policiclici aromatici. L’introduzione della misura strutturata di nuovi parametri, appare particolarmente rilevante sia per comprendere meglio le caratteristiche degli inquinanti e indirizzare al meglio le azioni di risanamento, che per approfondire gli studi relativi agli impatti sanitari delle diverse sostanze presenti in atmosfera.
L’obiettivo è di mettere in campo al più presto le misure necessarie per ridurre l’inquinamento atmosferico al di sotto dei limiti proposti, o almeno a ridurre al minimo il periodo di superamento, con la prospettiva di raggiungere il loro rispetto su tutto il territorio entro il 2030. I piani dovranno inoltre essere monitorati costantemente per verificarne l’effettiva implementazione ed aggiornati regolarmente qualora per tre anni consecutivi persista il superamento dei limiti.
La tutela sanitaria dei Cittadini
Altro importante obiettivo perseguito dall’Atto è quello della garanzia di una maggiore tutela sanitaria per i cittadini.
Ciò dovrà essere realizzato mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico.
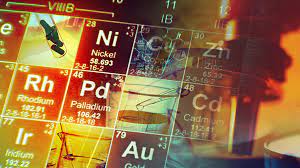


On-line il nuovo sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Possile ora la Ricerca di nominativi per il ruolo di Responsabile Tecnico
È on-line la nuova versione del sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Vediamo quali sono le principali funzionalità e le metodologie di ricerca delle figure dei responsabili tecnici gestione rifiuti (RT).
Cosa c’è di nuovo
L’obiettivo è quello di avvicinare sempre di più l’Albo Gestori agli utenti e facilitare lo scambio di informazioni normative e funzionali, sempre con riguardo alla sicurezza dei dati e alla velocità di fruizione. Il nuovo sito è stato sviluppato sulla base delle tecnologie più avanzate e tenendo presente tre concetti cardine: usabilità, accessibilità e comunicazione.
Nella nuova versione sono presenti nuove pagine con aree dedicate a:
- la ricerca di contenuti all’interno del sito;
- le Sezioni dell’Albo;
- le iniziative legate alla legalità;
la newsletter, con archivio e modalità di iscrizione.
La ricerca degli RT
Chi sono gli RT
Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono nominare almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente, o anche da un soggetto esterno all’organizzazione.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 sui compiti che il responsabile tecnico deve svolgere per ogni categoria.
In cosa consiste la funzionalità di ricerca
Nell’area riservata di ciascuna impresa iscritta, è possibile accedere alla funzionalità “Ricerca RT” che consente di visionare l’elenco dei responsabili tecnici, con i relativi requisiti, per coprire le eventuali necessità di ricerca di questa figura, indispensabile per mantenere attiva l’iscrizione alla specifica categoria e classe.
Per maggiori informazioni

MPC – MASE: Riattivata la Piattaforma Nazionale del Fosforo
E’ stata riattivata la “Piattaforma Nazionale del Fosforo”, gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Vediamo di cosa si tratta e l’importanza del fosforo come materia prima critica.
La piattaforma di nuovo al via
Di nuovo al via le attività della Piattaforma Nazionale del Fosforo. Un nuovo accordo di collaborazione biennale tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’ENEA consente il rilancio del lavoro di una Piattaforma che riunisce tutti i soggetti portatori di interesse della catena di valore del fosforo.
Il fosforo come materia prima critica
Innanzitutto, occorre vedere di quale materia prima critica si tratta e il problema generato.
Si tratta di una risorsa non rinnovabile, non sostituibile, fondamentale per la produzione alimentare, essenziale per l’agricoltura e direttamente legata alla sicurezza alimentare, oltre ad essere importante in una serie di altre applicazioni industriali. Le riserve minerali mondiali di fosforo sono limitate anche se si discute ancora sull’estensione e concentrazione geografica delle stesse.
Tuttavia, agli attuali ritmi di prelievo di materie prime e produzione alimentare, il fabbisogno di fosforo rimarrà elevato. Allo stesso tempo le perdite di fosforo determinano gravi impatti ambientali. Il fosforo è la sostanza che maggiormente contribuisce all’eutrofizzazione delle acque ed allo scadimento della qualità delle acque superficiali.
Le problematiche di sostenibilità del fosforo sono strettamente legate ad altre sfide cruciali incluse la gestione dell’azoto, il trattamento delle acque, gli scarti alimentari, l’erosione del suolo, la sicurezza alimentare.
Il fosforo è inserito nell’elenco delle “Critical Raw Materials” redatto dalla Commissione europea.
Formano una solida base industriale, producendo un’ampia gamma di beni e applicazioni utilizzate nella vita quotidiana e nelle moderne tecnologie. L’accesso affidabile e senza ostacoli a determinate materie prime è una preoccupazione crescente all’interno dell’UE e in tutto il mondo. Per affrontare questa sfida, la Commissione europea ha creato un elenco di materie prime critiche (CRM) per l’UE, che è soggetto a regolare revisione e aggiornamento. I CRM combinano materie prime di grande importanza per l’economia dell’UE e ad alto rischio associato alla loro fornitura.
In particolare, la loro importanza è giustificata da:
- Collegamento con l’industria : le materie prime non energetiche sono collegate a tutte le industrie in tutte le fasi della catena di approvvigionamento
- Tecnologia moderna : il progresso tecnologico e la qualità della vita dipendono dall’accesso a un numero crescente di materie prime. Ad esempio, uno smartphone può contenere fino a 50 diversi tipi di metalli, ognuno dei quali contribuisce alle sue dimensioni ridotte, leggerezza e funzionalità.
- Ambiente : le materie prime sono strettamente legate alle tecnologie pulite. Sono insostituibili nei pannelli solari, nelle turbine eoliche, nei veicoli elettrici e nell’illuminazione ad alta efficienza energetica.
Il fosforo è considerato una materia prima critica per l’Europa, a causa della dipendenza dalle importazioni da Paesi extra europei (84% per la roccia fosfatica e 100% per il fosforo elementare) e del basso tasso di riciclo da prodotti a fine vita (17% per la roccia fosfatica e nullo per il fosforo elementare). Tuttavia, il fosforo è una risorsa essenziale per la vita, non rinnovabile e non sostituibile, che trova un largo impiego in molti mercati. La quasi totalità del fosforo elementare viene impiegato nell’industria chimica per la produzione di fertilizzanti per l’agricoltura (82%) e in via residuale nel settore della metallurgia (5%) e nel settore dell’elettronica (5%).
In generale, sono considerate come tali quelle fondamentali per l’economia europea.
La piattaforma del fosforo
Nel 2019 il Ministero ha promosso la nascita della Piattaforma, gestita da ENEA in collaborazione con la Direzione Generale Economia Circolare del MASE, tra le cui finalità c’è il raggiungimento dell’autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee, attraverso lo sviluppo di un modello di economia circolare. Vi partecipano più di 60 organizzazioni aderenti, tra cui realtà della ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e terzo settore.
Webinair informativo
Il prossimo 15 marzo è previsto un webinar per illustrare gli obiettivi operativi per il biennio 2023-2024, assieme a maggiori dettagli su organizzazione e attività specifiche previste.
Per maggiori informazioni
Cliccare qui: https://www.piattaformaitalianafosforo.it/

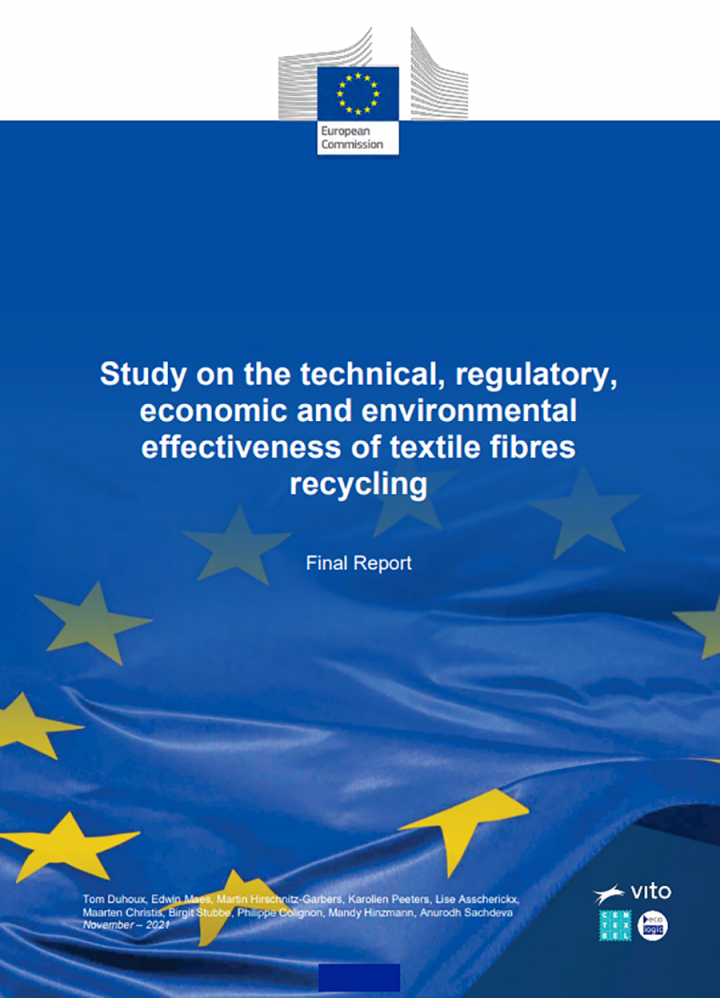
Commissione europea: si stanno compiendo sforzi per passare a un’economia tessile più circolare e sostenibile
Con uno studio rilasciato a Novembre 2021, viene testimoniato l’impegno dell’Europea per lanciare un economia dei rifiuti tessili che sia più circolare e sostenibile che mai. Con lo “Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness of textile fibres recycling”, l’Europea delinea le tecnologie di trattamento utilizzate, e un analisi economica di rendimento delle stesse, applicate al recupero delle fibre divenute rifiuti.
In sintesi
Con i risultati dello studio, la Commissione intende fornire evidenti evidenze empiriche per migliorare la conoscenza e l’efficacia delle capacità di riciclaggio dei rifiuti tessili.
In esso si affrontano le tecnologie esistenti, sia quelle che sono applicate a livello industriale che in fase di sviluppo, relative alle diverse modalità di recupero come materia (es. riciclaggio meccanico, monomero chimico riciclaggio, riciclaggio di polimeri chimici, ecc.).
Inoltre, viene delineata un un’analisi economica ed efficacia ambientale di tali tecnologie di riciclaggio e una tabella di marcia delle tecnologie di riciclaggio dei tessili in fase di sviluppo al fine di supportarne l’adozione industriale.
Da ultimo vengono riportate le iniziative politiche pertinenti al fine di sviluppare il potenziale dell’economia in esame, e quali sono le barriere normative da abbattere per intensificare le attività di riciclaggio dei rifiuti tessili nell’UE.
Alcuni dati
L’economia dei rifiuti tessili presenta un rilevante potenziale. Basti un dato per giustificare tale affermazione. Secondo i dati forniti dalla Commissione, infatti ogni cittadino europeo:
- utilizza in media 26 kg di materiale tessile pro-capite.
- produce 11,3 kg di rifiuti, per un valore, in termini assoluti, pari a 5,8 milioni di tonnellate all’anno.
La produzione e il trasporto di tessuti richiedono 1,3 tonnellate di materie prime primarie, 100.000 litri di acqua e 700 m² di terra per persona all’anno.
Perché è stato promosso lo studio
L’Europea crede fermamente in questo settore: uno dei principali obiettivi della Commissione è proprio quello rafforzare la competitività dell’UE dell’industria tessile e dell’abbigliamento, laddove avanza la sua trasformazione verde e digitale.
Aumentare l’efficienza delle risorse e aiutare i ricercatori dell’UE e l’industria tessile e dell’abbigliamento europea, è l’obiettivo dell’analisi, da cui emerge che l’Europe è un leader, a livello globale, nella nascente circolare, nei modelli di business e nelle tecnologie legate al riciclo, poiché rende conoscenze sostanziali sullo stato di avanzamento e lo stato dell’arte, le opportunità e gli effetti collaterali negativi del tessile raccolta differenziata.
In particolare si vuole:
- migliorare la conoscenza delle opportunità e le sfide delle tecnologie di riciclaggio dei rifiuti tessili, sviluppate e applicate a livello globale e livello dell’UE per quanto riguarda la loro fattibilità tecnica e maturità per l’adozione da parte del mercato e, efficacia economica e ambientale;
- identificare aree promettenti per la ricerca futura e progetti di innovazione e le misure necessarie per sostenere l’adozione industriale del tessile tecnologie di riciclaggio già in fase di sviluppo;
- fornire ai responsabili politici un un’analisi approfondita degli ostacoli normativi esistenti e presentare opzioni politiche alternative migliorare e potenziare le attività di riciclaggio dei rifiuti tessili nell’UE.
Le varie modalità di recupero dei rifiuti tessili
In tema di recupero come materia del rifiuto in esame, la Commissione distingue, in particolare, le seguenti tecnologie.
Il riciclaggio meccanico
si tratta di un processo basato su forze fisiche, che possono essere utilizzate in isolamento per il riciclaggio di tessuti o fibre o come pre-lavorazione per termomeccanici o chimici e processi di riciclo biochimico. La tecnologia di riciclaggio è attualmente a Livello di preparazione 9 (TRL 9) ed è già una tecnologia affermata sul mercato decenni di esperienza, ad esempio, per la lana nella regione di Prato in Italia o altri naturali fibre (a base di cellulosa come cotone, juta, sisal, lino, ecc.) e anche fibre sintetiche (poliestere, poliammide, acrilico, viscosa, PP, ecc.) in varie regioni europee (Belgio, Francia, Germania, Svezia, ecc.).
Il riciclo termico
Con il riciclo termico, invece, si realizza un processo basato sul riscaldamento con l’obiettivo di recuperare entrambi i polimeri o blocchi costitutivi a basso peso molecolare. Viene fatta una distinzione tra riciclaggio termomeccanico e riciclaggio termochimico.
Il riciclaggio termomeccanico
Si tratta di un processo utilizzato in un sistema di riciclaggio che fonde un polimero, tipicamente impiegato per consentire il riciclaggio dei polimeri. Queste sono tecnologie per il riciclaggio tessuti termoplastici, ad es. poliestere, poliammide, polipropilene, ecc. mediante lavorazione a fusione trasformarli in un rigranulato e/o nuove fibre.
Il riciclaggio termochimico
Con quello termochimico, invece, viene utilizzata la reazione di ossidazione parziale dei polimeri per produrre componenti a bassa massa molare o riscaldare per degradare i polimeri in monomeri che possono essere utilizzato come materia prima per l’industria chimica, ad esclusione dei combustibili utilizzati per l’energia
produzione o altri processi di combustione o recupero energetico.
Viene considerata come una tecnologia matura, sebbene dia luogo alla produzione di materie prime per la l’industria chimica (al contrario del recupero energetico o della produzione di combustibili).
Il riciclaggio chimico
Si tratta di un processo che utilizza la dissoluzione chimica o reazioni chimiche impiegati nel riciclo dei polimeri (sistema di smontaggio di fibre usate, estrazione di polimeri e rifilarli per nuovi usi) o il riciclo dei monomeri (sistema di scomposizione materiali tessili polimerici nei loro monomeri costituenti e ricostruzione di fibre polimeriche per nuovi usi).
Per maggiori informazioni
Cliccare qui: https://www.centexbel.be/sites/default/files/inline-files/DGgrow-study-textile-recycling_0.pdf
Advertising
Book
Disponibile on-line, su Amazon on-line shop, il secondo volume de “L’economia circolare dispiegata”, “La gestione dei rifiuti: per Aziende, Cittadini, Enti pubblici”, dedicato a chi vuole approfondire i temi dell’economia ambientale, della gestione dei rifiuti e della relativa disciplina tariffaria, sotto un profilo economico, legislativo e tributario.
E’ in libreria e sullo shop-on line di Amazon, il mio nuovo volume dedicato alle “Procedure Autorizzative Ambientali IIa Edizione. Cosa cambia con il “Semplificazioni bis” (DL n. 77/2021/)”.
Per comprare il Volume
Cliccare qui.
Advertising
Book
Le “Procedure Ambientali” costituisce il primo volume della nuova collana dal titolo “L’Economia circolare dispiegata”, il visibile filo rosso che lega assieme le diverse monografie che la compongono, ciascuna delle quali è stata sviluppata con l’obiettivo di evidenziare i principi cui dovrebbero essere ispirati i modi di operare di cittadini, imprese, e pubbliche amministrazioni chiamati ad implementarli, i quali possono rendere, se correttamente attuati, “circolare” il nostro sistema economico. Per acquistare la tua copia, clicca qui!


